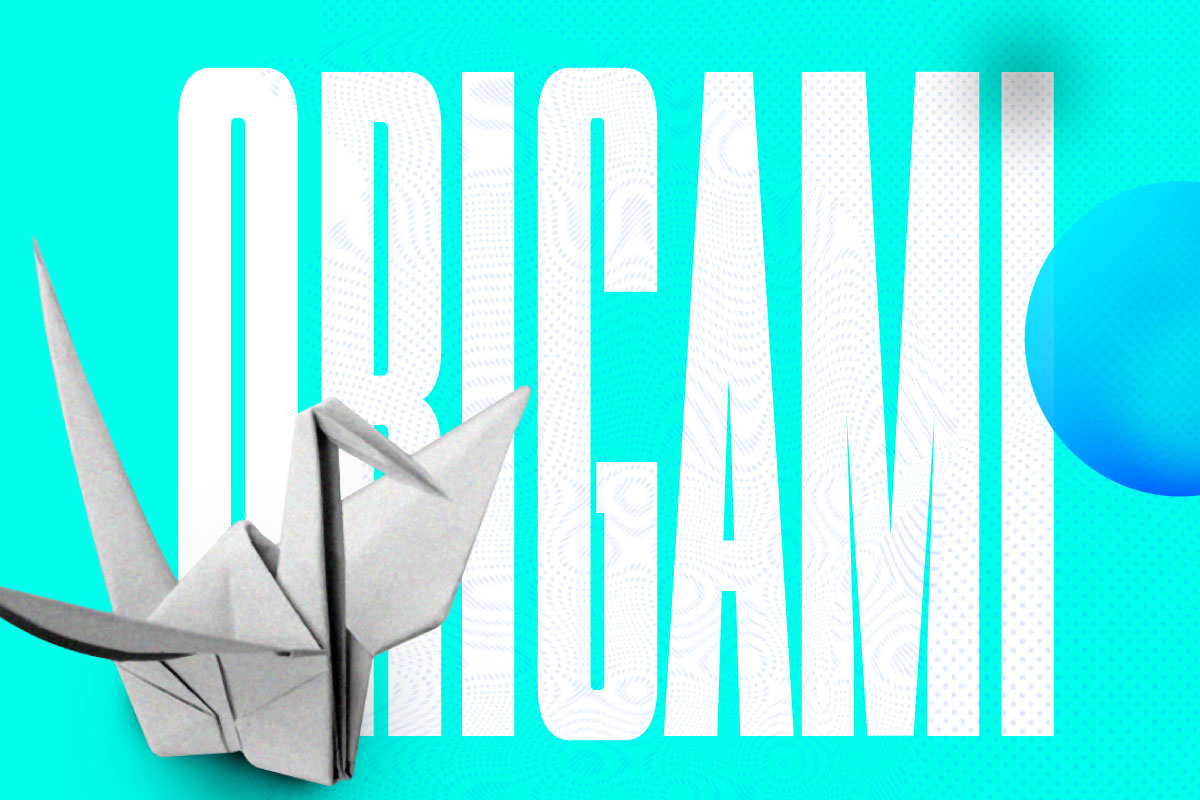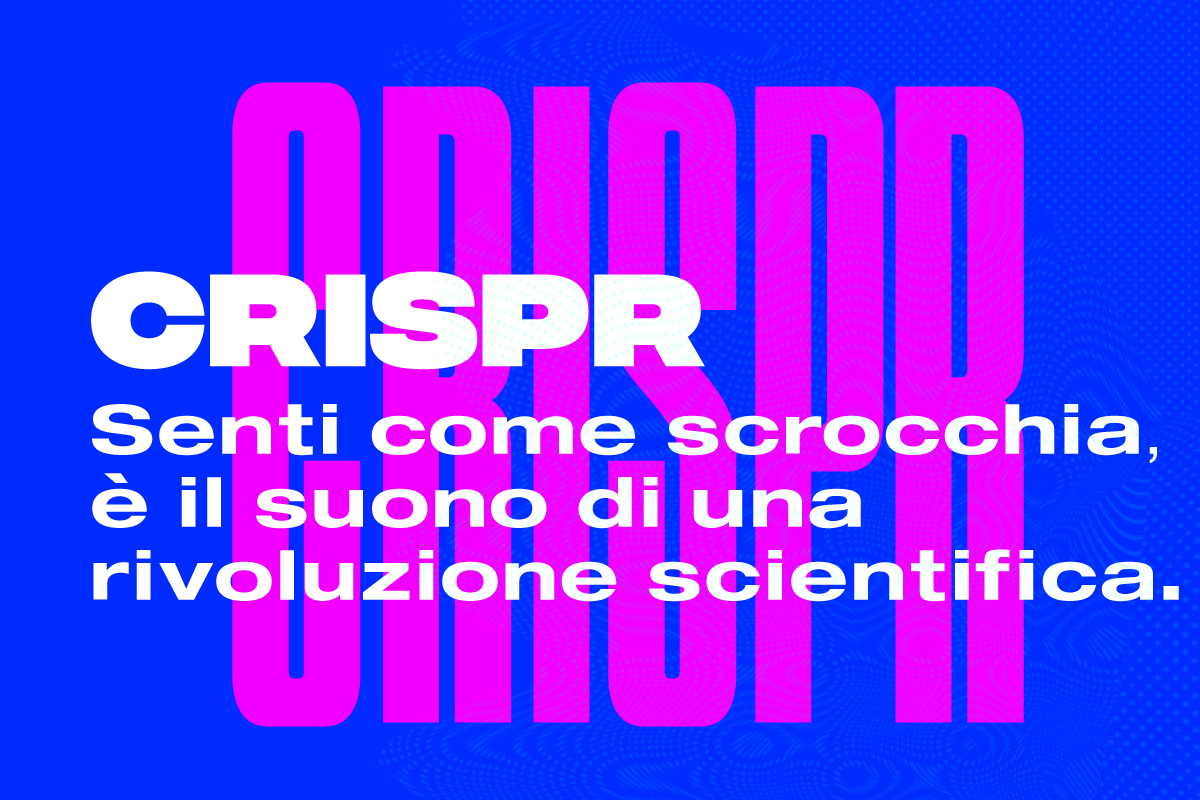DNA-origami: nanostrutture per i materiali del futuro
In che modo possiamo utilizzare il DNA come materia prima per costruire nanoparticelle? E quali sono le opportunità che questa frontiera delle nanotecnologie offre, anche in medicina?
Ripiegare i filamenti di DNA, con altissima precisione, e riorganizzarli realizzando strutture bi- e tridimensionali da impiegare come veicolo per il trasporto di sostanze, o come materiali per la costruzione di impalcature via via più complesse per realizzare dispositivi elettronici in piccolissima scala. È questo quanto si intende con DNA-origami, una tecnica che ricorda – come suggerisce il nome – l’antica arte giapponese di costruire oggetti piegando opportunamente dei foglietti di carta. Ma, in questo caso, lo scopo è completamente diverso da quello ornamentale, e spazia dalla diagnostica alla cura di malattie come il cancro. Ecco da vicino di cosa si tratta e a che punto è la ricerca su questo fronte delle nanotecnologie.
Perché gli origami (e perché proprio il DNA)?
Quando guardiamo da vicino le molecole coinvolte nei processi che regolano, fanno ammalare o curano il nostro organismo, ciò che conta non è solo la sostanza in gioco, ma anche la forma. Per trattare il cancro, per esempio (così come per una grande quantità di altre patologie) non è sufficiente ottenere un principio attivo efficace: è fondamentale anche che questo, grazie anche alla sua forma tridimensionale, sia in grado di raggiungere il proprio bersaglio all’interno del corpo e che possa qui svolgere la propria funzione, possibilmente col minor impatto possibile sui tessuti sani. Per farlo, è necessario selezionare il vettore più idoneo al trasporto della sostanza in questione e, molto spesso, questa scelta è guidata dalla conformazione spaziale del vettore. Il principio di base degli origami, cioè di progettare e realizzare strutture con un preciso ordinamento spaziale, ben si presta a soddisfare queste esigenze se reinterpretato in scala nanoscopica, nell’ordine dei miliardesimi di metro.
La particolare struttura del DNA, una lunga elica formata da due filamenti di unità elementari ripetute e accoppiate tra loro in modo specifico, rende questa molecola particolarmente adatta a costruire oggetti in scala nanometrica ben definiti dal punto di vista spaziale. Proprio per il fatto che il DNA abbina le basi in modo prevedibile, è possibile – progettando in modo opportuno le sequenze dei filamenti – indurre tali filamenti ad auto-assemblarsi nelle strutture desiderate. Il DNA può dare luogo a nuove forme, grazie alle sue proprietà chimiche intrinseche, e per questo è per gli scienziati un ottimo candidato a realizzare ciò che in gergo è chiamato in inglese scaffold (“impalcatura”) per la costruzione di materiali tecnologicamente avanzati o per lo sviluppo di vettori da “caricare” e dirigere verso specifici bersagli in ambito biomedico.
Strutture realizzate a partire dal DNA hanno inoltre dalla loro la possibilità di essere molto stabili, robuste e di poter essere facilmente funzionalizzate, cioè arricchite con ulteriori molecole – siano essi farmaci, antigeni o altre unità deputate al riconoscimento e al legame con precisi recettori di cellule e tessuti. Ultimo (ma non meno importante) aspetto per l’impiego di questa materia prima in biomedicina, il fatto che si tratti di una molecola di per sé biocompatibile e biodegradabile.
Come tutto è cominciato
La prima pubblicazione scientifica sul DNA-origami risale al 2006: in un articolo pubblicato su Nature, un bioingegnere computazionale del Caltech di Pasadena, Paul Rothemund, metteva per la prima volta nero su bianco un metodo per ottenere, in un unico passaggio, figure geometriche bidimensionali a partire da lunghi singoli filamenti di DNA ripiegati in modo strategico. Un po’ come se ai filamenti corrispondessero lunghi nastri ai quali far comporre, a comando, le immagini desiderate.
Si trattava, in quell’occasione, di figure piuttosto semplici: quadrati, triangoli, fiori geometrici, una stella e un fiocco di neve stilizzati, uno “smile” (la faccina sorridente che compare tra gli emoticon, per intenderci). L’opera più complessa, e che infatti richiamò attenzione, fu una vera e propria mappa in miniatura delle Americhe. “Questa è solo arte”, fu il commento dello scienziato in occasione dell’uscita dell’articolo. Tuttavia, l’ambizione era di sviluppare quanto prima dispositivi che trovassero applicazione nel campo dell’elettronica, come per esempio supporti per componenti microscopiche, oppure in biologia molecolare, previa funzionalizzazione con molecole dall’attività specifica, in particolare enzimi.
Proprio come l’antica arte giapponese ha consentito nella storia di ottenere modelli tridimensionali di animali e altri oggetti di complessità anche molto elevata, gli scienziati al lavoro sul DNA hanno accolto la sfida di realizzare figure via via più sofisticate. Nel 2009, presso la Harvard Medical School di Boston, fu il momento dei primi oggetti in tre dimensioni: cubi, reticoli e una varietà di altre strutture che segnarono un passo decisivo nella progettazione su scala nanometrica di oggetti di biologia sintetica. Ma cosa possiamo fare davvero oggi grazie ai DNA-origami?
La lunga strada verso l’applicazione
La letteratura degli ultimissimi anni può darci il polso di quanto rapidamente gli oggetti nanoscopici che si possono realizzare siano diventati complessi, ma anche di quanto la strada da percorrere per utilizzare nella pratica questi oggetti, soprattutto in ambito clinico (laddove si presuppone un contatto con le cellule e i tessuti del nostro corpo), sia ancora molto, molto lunga.
Dal punto di vista operativo, è oggi possibile ottenere una moltitudine di origami di DNA grazie allo sviluppo, a poco più di 15 anni dalla prima pubblicazione, di una grande varietà di tecniche. Allo stesso tempo, però, la capacità di produrre strutture di questo tipo con specifiche funzioni su larga scala è ancora limitata e rappresenta l’ostacolo più imponente oggi sul versante tecnologico, soprattutto nell’ottica delle applicazioni biomediche. Ci sono anche molti interrogativi riguardo agli aspetti tossicologici e, in generale, al comportamento che questi oggetti possono assumere all’interno di un organismo e nel tempo.
Al di là di queste incognite che andranno chiarite in accurati studi preclinici e clinici, la comunità scientifica internazionale reputa il potenziale del DNA-origami piuttosto elevato per la diagnostica e per veicolare farmaci (qui uno degli ultimi articoli nell’ambito di studi di oncologia sperimentale) . Ma non solo. Il DNA-origami potrebbe essere usato anche come strumento per progettare e sviluppare vaccini. Una ricerca del Mit di Boston, i cui risultati sono stati pubblicati proprio a giugno 2020 su Nature Nanotechnology, per esempio, ha dimostrato che capsule realizzate con filamenti di DNA e ricoperte da proteine tipiche di un virus possono essere “confuse” dal nostro organismo col virus che si incontra in natura per questo potrebbero essere efficaci nell’innescare una reazione immunitaria come quella indotta dalle vaccinazioni. È stato osservato, per ora, solo in laboratorio, e solo nel caso del virus dell’Hiv, ma, sostengono gli autori della ricerca, se i risultati degli studi successivi saranno incoraggianti, l’approccio potrebbe essere esteso anche alle proteine di altri virus, per esempio quello che causa il Covid-19, al cui vaccino gli scienziati del Mit stanno già lavorando.
Alice Pace